Responsabilità civile e intelligenza artificiale: verso un nuovo paradigma giuridico?
- lexplorepro
- 24 apr 2025
- Tempo di lettura: 4 min
Aggiornamento: 28 apr 2025
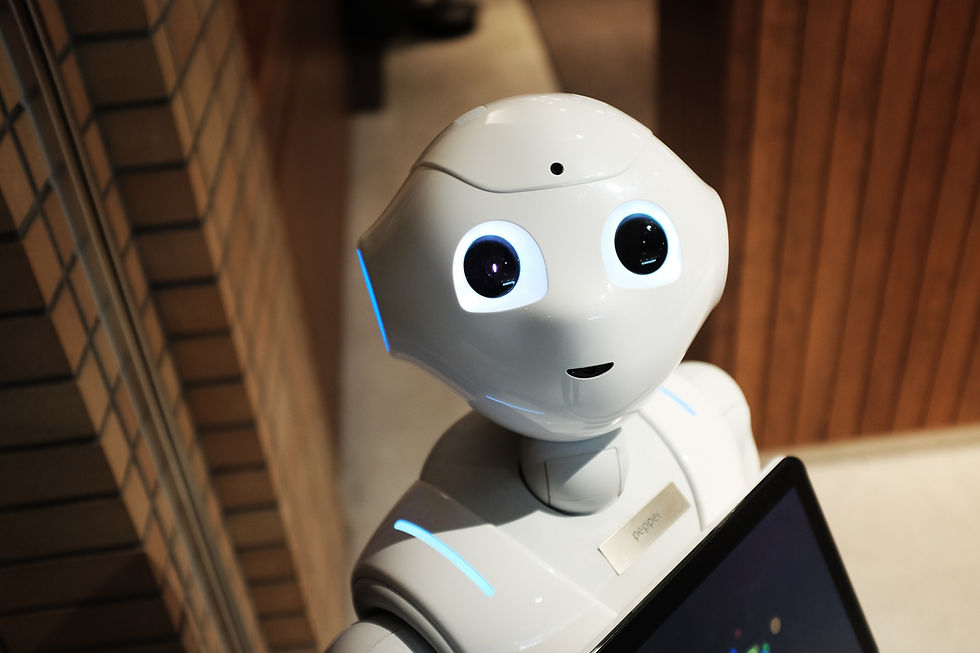
Quando un algoritmo causa un danno, chi ne risponde? Il nostro Codice Civile è pronto ad affrontare le sfide dell’intelligenza artificiale?
Introduzione – L’IA non sbaglia, ma può fare danni
L’intelligenza artificiale (IA) sta cambiando radicalmente il modo in cui viviamo e lavoriamo. È dietro alle auto a guida autonoma, agli assistenti digitali, ai software che selezionano CV, ma anche ai sistemi che decidono chi ha diritto a un prestito o a un beneficio sociale.
Ma quando qualcosa va storto? Quando una decisione presa da un algoritmo danneggia una persona—magari negandole un diritto, o peggio, causando un danno fisico—chi è responsabile? È una domanda che mette in crisi il cuore della responsabilità civile italiana, ancora fortemente legata alla colpa umana.
Il modello italiano: un codice “umano-centrico”
La responsabilità civile in Italia si fonda principalmente sull’articolo 2043 del Codice Civile, che recita: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”
Questo schema implica:
l’esistenza di un fatto umano;
un comportamento doloso o colposo;
un danno ingiusto;
un nesso causale tra fatto e danno.
Ma cosa succede quando il “fatto” non è umano, bensì generato da un sistema autonomo o semi-autonomo? È ancora possibile parlare di colpa? E se non c’è nessuno che ha “sbagliato” direttamente?
IA e diritto: problemi di imputazione e causalità
Applicare il modello tradizionale alla IA solleva almeno tre ordini di problemi:
1. L’opacità dell’algoritmo
Molti sistemi IA, soprattutto quelli basati sul machine learning, sono “black box”: anche gli stessi sviluppatori non possono sempre spiegare perché il sistema abbia preso una certa decisione. Questo rende difficile individuare il nesso causale.
2. L’autonomia della macchina
Quando un algoritmo agisce in autonomia, senza che un essere umano decida ogni singola azione, a chi si può imputare il comportamento? È ancora giusto parlare di colpa dell’utilizzatore o del produttore?
3. La pluralità dei soggetti coinvolti
Nel ciclo di vita di un sistema IA ci sono molti attori: sviluppatori, integratori, fornitori di dati, utilizzatori finali. Qual è quello “giuridicamente” responsabile?
Gli strumenti del Codice Civile: adattamenti possibili
Di fronte a queste sfide, i giuristi italiani stanno esplorando vie interpretative alternative per applicare norme già esistenti.
Art. 2050 c.c. – Attività pericolose
Questo articolo prevede una responsabilità presunta per chi svolge attività pericolose. Se l’IA viene considerata tale (soprattutto nei settori sanitari, automobilistici o finanziari), il danneggiato non deve provare la colpa, ma solo il nesso tra attività e danno.
Esempio: un robot chirurgico provoca una lesione durante un’operazione. Potrebbe configurarsi una responsabilità “pericolosa” in capo all’ospedale.
Art. 2049 c.c. – Responsabilità per fatto altrui
Si applica tradizionalmente ai datori di lavoro per i danni causati dai dipendenti. Alcuni studiosi propongono di estenderlo analogicamente all’uso di sistemi IA, considerandoli come una sorta di “ausiliari digitali”.
Esempio: un’azienda usa un algoritmo per decidere promozioni interne e questo discrimina una dipendente. Si potrebbe chiamare in causa l’azienda, come se l’IA fosse un suo rappresentante.
Codice del Consumo – Prodotto difettoso
Il D.Lgs. 206/2005, che recepisce la direttiva europea sulla responsabilità da prodotto, può essere applicato quando il sistema IA è incorporato in un “bene” (es. un robot, un’app, un software venduto). In tal caso, si può parlare di prodotto difettoso.
➡️ Esempio: un software venduto a una banca prende decisioni errate per un bug. Il consumatore può chiedere il risarcimento al produttore.
L’Europa accelera: AI Act e proposta di Direttiva sulla responsabilità
Mentre l’Italia cerca soluzioni nel proprio sistema, l’Unione Europea ha già avviato una rivoluzione normativa. Nel 2024 è stato approvato l’AI Act, che:
Classifica i sistemi IA in base al rischio (basso, medio, alto, inaccettabile);
Impone obblighi di sicurezza e trasparenza per quelli ad alto rischio;
Introduce forme di controllo umano e auditabilità tecnica.
In parallelo, la Proposta di Direttiva sulla responsabilità da IA mira a:
Invertire l’onere della prova per i danni causati da IA ad alto rischio;
Estendere la responsabilità oggettiva al produttore o al “deployer” del sistema.
Verso un nuovo diritto? Il dibattito accademico italiano
La dottrina italiana è divisa tra due visioni:
1. L’adattamento del diritto esistente
Alcuni ritengono che bastino interpretazioni evolutive delle norme attuali, con l’aiuto della giurisprudenza.
2. La creazione di una nuova disciplina
Altri sostengono che sia necessario un nuovo diritto della responsabilità algoritmica, che tenga conto della natura autonoma e non prevedibile dell’IA.
Alcune proposte:
Personalità giuridica elettronica per IA avanzate;
Sistemi assicurativi obbligatori per chi sviluppa o impiega IA;
Fondi pubblici di compensazione, sul modello di quelli per le vittime della strada o del vaccino.
Conclusione – Il diritto italiano è pronto?
La responsabilità civile in Italia si trova davanti a una sfida inedita: riconoscere i danni causati da sistemi non umanisenza rinunciare ai principi fondamentali del nostro ordinamento.
Oggi il nostro Codice Civile offre ancora strumenti utili, ma non sempre sufficienti. Serve un lavoro di aggiornamento che coinvolga giuristi, sviluppatori, giudici e politici. L’innovazione non si può fermare, ma nemmeno può lasciare le vittime senza tutela.
In attesa di riforme strutturali, la soluzione più realistica è forse un mix: usare le norme esistenti dove possibile, ma affiancarle a nuove regole speciali, calibrate sui rischi dell’IA.



Commenti